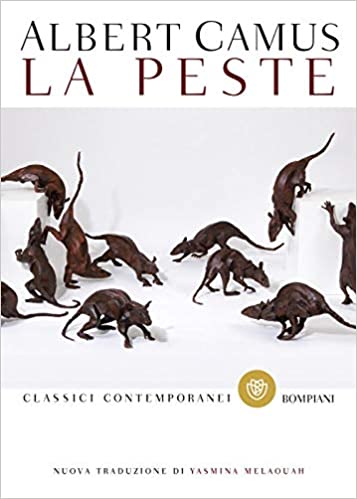
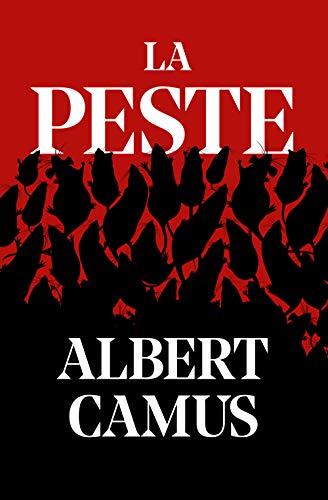
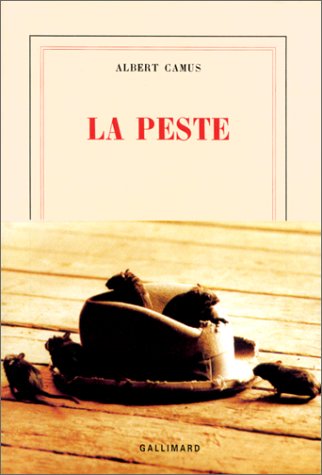
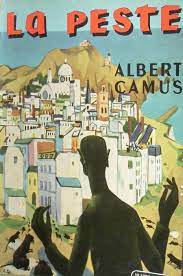

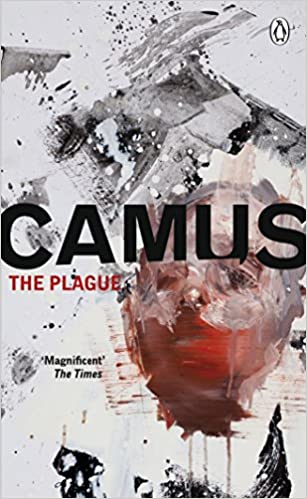
Albert Camus (Dréan, Algeria 1913 – Villeblevin, Francia 1960)
Albert Camus è nato in Algeria, a quei tempi colonia francese, nel 1913. Malatosi giovanissimo di tubercolosi, riesce ugualmente a terminare i suoi studi in filosofia nel 1936. Negli anni ’30 la tubercolosi non conosceva ancora cura e questa condizione, insieme al clima bellico nel quale era cresciuto, ha quasi sicuramente influenzato le tematiche e la filosofia della opere di Camus. Antifascista, Camus vive il periodo della seconda guerra mondiale prima e quello della guerra fredda poi da giornalista, filosofo, saggista, e grande attivista politico. Nel 1957 riceve il premio Nobel per la letteratura per poi morire nel 1960 a causa del peggiorarsi della tubercolosi.
L’assurdo è probabilmente il tema principale e filo conduttore delle opere di Camus. L’assurdità del comportamento e delle reazioni degli uomini nei confronti della vita viene analizzata dall’autore all’interno di una riflessione sull’esistenza umana. Il manifestarsi dell’assurdo avviene all’interno del rapporto che l’uomo instaura con il mondo esterno e al ruolo che il destino ricopre nella vita di ognuno. L’assurdo, ostacolando la sincera formazione di legami fra gli uomini, porta a divisioni, individualismo ed egoismi. Come vincere l’assurdo? Con una presa di coscienza, una nuova consapevolezza spirituale che porta a lavorare con gli altri per superare, attraverso la solidarietà, l’assurdità della vita.
La Peste (1947) incarna tutto questo. “La Peste” rappresenta la lotta, la sopportazione e la rassegnazione nei confronti di un male contro il quale l’uomo può fare ben poco se non reagire con i mezzi che ha a disposizione e sperare che questi funzionino (e che la malattia si decida ad abbandonare la città). “La Peste” ci ricorda che, una volta che ci spogliamo di tutto il superfluo, siamo tutti esseri umani con gli stessi desideri e le stesse paure perché abbiamo molte più cose in comune che ci uniscono di quante possano essere le differenze che apparentemente ci dividono. Quindi…cosa rimane da fare? Secondo Camus, uno dei modi migliori per arrivare a riconoscere, sopportare ed eventualmente superare l’assurdità dell’esistenza umana è quello di esplorare noi stessi nella solidarietà con gli altri con lo scopo di creare legami sinceri che possano resistere al dolore e alle sofferenze della vita.
Inutile sottolineare le analogie con il periodo storico che stiamo vivendo. Tuttavia, vorrei soffermarmi sulla forza che parole del passato riescono a trasmettere anche a decine (a volte centinaia) di anni di distanza. La magia della letteratura penso stia proprio in questo; nel ricordarci che il mondo può cambiare, possono cambiare le tecnologie e le modalità attraverso cui le persone comunicano fra di loro ma le fragilità, le necessità, i sogni e i desideri dell’essere umano rimangono profondamente e in maniera quasi viscerale gli stessi.
DIFFICOLTA’: bassa (una seconda lettura è consigliata, ma non indispensabile)
LINGUA ORIGINALE: Francese (disponibile in italiano)
PARTE PRIMA
Una maniera facile per far la conoscenza d’una città è quella di cercare come vi si lavora, come vi si ama e come vi si muore.
p. 6
… a Orano, come altrove, in mancanza di tempo e di riflessione, si è costretti ad amarsi senza saperlo.
p. 7
Domanda: come fare per non perdere
p. 27
il proprio tempo?
Risposta: provarlo in tutta la sua durata.
I flagelli, invero, sono una cosa comune, ma si crede difficilmente ai flagelli quando ti piombano sulla testa. Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre; e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati.
pp. 37-38
Quando scoppia una guerra, la gente dice: “Non durerà, è cosa troppo stupida.” E non vi ha dubbio che una guerra sia davvero troppo stupida, ma questo non le impedisce di durare. La stupidaggine insiste sempre, ce se n’accorgerebbe se non si pensasse sempre a sé stessi.
p. 38
I nostri concittadini non erano più colpevoli d’altri, dimenticavano di essere modesti, ecco tutto, e pensavano che tutto era ancora possibile per loro, il che supponeva impossibili flagelli. Continuavano a concludere affari e a preparare viaggi, avevano delle opinioni. Come avrebbero pensato alla peste, che sopprime il futuro, i mutamenti di luogo e le discussioni? Essi si credevano liberi, e nessuno sarà mai libero sino a tanto che ci saranno i flagelli.
p. 38
Ma cosa sono cento milioni di morti? Quando si fa la guerra, appena appena si sa che cosa sia un morto. E siccome un uomo morto non ha peso che quando lo si é veduto, cento milioni di cadaveri sparsi traverso la storia non sono che una nebbia nella fantasia. (…) Diecimila morti fanno cinque volte il pubblico d’un grande cinematografo. Eco, bisognerebbe far questo: radunare le persone all’uscita di cinque cinematografi, condurli in una piazza della città e farle morire in un mucchio per vederci un po’ chiaro. Almeno, si potrebbero allora mettere dei visi noti su quel cumulo anonimo. Ma, naturalmente, é impossibile far questo; e poi, chi conosce diecimila visi?
p. 39
Ma insomma, lo si poteva fermare. Quello che bisognava fare era riconoscere chiaramente quello che doveva essere riconosciuto, cacciare infine le ombre inutili e prendere le misure necessarie.
p. 41 (in riferimento al flagello della peste)
Ma per evocare emozioni sì semplici, la minima parola gli costava mille pene.
p. 47
Richard dichiarò che, secondo lui, non bisognava cedere alla paura: si trattava d’una febbre con complicazioni inguinali, era tutto quello che si poteva dire, essendo le ipotesi, nella scienza come nella vita, sempre pericolose. (…) [Castel] sapeva benissimo ch’era la peste, ma che, beninteso, il riconoscimento ufficiale avrebbe costretto a prendere misure spietate. Egli sapeva che, in fondo, era questo a far indietreggiare i colleghi e, pertanto, voleva ben credere, per la loro tranquillità, che non fosse peste.
p. 48
“L’importante” disse Castel “non è che sia un bel modo di ragionare, ma che faccia riflettere.”
p. 49
I focolai infettivi sono in crescente diffusione. Al passo con cui la malattia si spande, se non è bloccata, rischia di uccidere mezza città prima di due mesi. Di conseguenza, poco importa che voi la chiamate peste o febbre di crescenza. Importa soltanto che voi le impediate di uccidere mezza città.
p. 49
Le misure non erano draconiane e sembrava che si fosse molto sacrificato al desiderio di non preoccupare l’opinione pubblica.
p. 51
La sera, la stessa folla riempiva le strade e le code si allungavano davanti ai cinematografi. D’altronde, il contagio sembrò retrocedere e per alcuni giorni si contò soltanto una decina di morti; poi, all’improvviso, di nuovo si impennò. Il giorno in cui la cifra dei morti ritoccò la trentina, Bernardo Rieux guardava il dispaccio ufficiale che il prefetto gli aveva passato dicendo: “Hanno avuto paura:” Il dispaccio recava: “Sia dichiarato lo stato di peste. La città sia chiusa.”
pp. 62-63
PARTE SECONDA
Da questo momento in poi si può dire che la peste fu cosa nostra, di tutti. Sino a qui, nonostante lo stupore e l’inquietudine suscitati da quei singolari avvenimenti, ciascuno dei nostri concittadini aveva proseguito le sue occupazioni, come gli era stato possibile, al suo solito posto. E certamente questo doveva continuare; ma una volta chiuse le porte, si accorsero di essere tutti, anche lo stesso narratore, presi nel medesimo sacco e che bisognava cavarsela.
p. 65
Si può dire che quest’invasione brutale della malattia ebbe per primo effetto di costringere i nostri concittadini ad agire come se non avessero sentimenti individuali.
p. 66
In verità, ci vollero parecchi giorni prima che ci rendessimo conto di trovarci in una situazione senza compromesso, in cui le parole “transigere,” “favore,” “eccezione” non avevano più significato.
p. 66
La separazione brutale, senza sbavature, senza un prevedibile futuro ci lasciava sconcertati, incapaci di reagire contro una presenza, ancora sì prossima e ormai sì lontana, che adesso occupava i nostri giorni. Infatti, soffrivamo due volte: prima di tutto della nostra sofferenza, e poi di quella che immaginavamo negli assenti, figli, sposa o amante.
p. 69
D’allora, insomma, ci si reintegrava nella nostra condizione di prigionieri, eravamo ridotti al nostro passato, e se anche alcuni di noi avevano la tentazione di vivere nel futuro, vi rinunciavano rapidamente, almeno per quanto gli era possibile, provando le ferite che la fantasia finisce con l’infliggere a coloro che hanno fiducia in lei.
p. 70
Provavano quindi la profonda sofferenza di tutti i prigionieri e di tutti gli esiliati, che è vivere con una memoria che non serve a nulla. (…) Impazienti del proprio presente, nemici del proprio passato e privi di futuro, somigliavano a coloro che la giustizia o l’odio degli uomini fa vivere dietro le sbarre.
p. 71
Ma s’era un esilio, nella maggioranza dei casi era un esilio in patria.
p. 71
Nonostante gli spettacoli insoliti, i nostri concittadini, apparentemente, faticavano a capire quello che gli era capitato. C’erano i sentimenti comuni, quali la separazione e la paura; ma s continuavano anche a mettere in prima linea le personali preoccupazioni. Nessuno aveva ancora accettato realmente la malattia; per la maggior parte, erano soprattutto sensibili a quello che turbava le loro abitudini o toccava i loro interessi. N’erano urtati o irritati, e non sono questi sentimenti che si possono opporre alla peste. La prima reazione, a esempio, fu di accusare l’amministrazione.
pp. 75-76
… l’annuncio che nella terza settimana di peste si erano contati trecentodue morti non parlava alla fantasia. D’altronde, non tutti forse erano morti di peste; inoltre, nessuno in città sapeva quante persone morissero alla settimana in tempi normali. (…) si ignorava se la proporzione dei decessi era la solita. (…) Il pubblico mancava, in qualche maniera, di punti di riferimento; soltanto assai più tardi, constatando l’aumento dei decessi, l’opinione prese coscienza della verità.
p. 76
Gli aumenti, almeno parlavano chiaro; ma non erano forti al punto che i nostri concittadini non conservassero, in mezzo alla inquietudine, l’impressione che si trattava d’un accidente noioso, di certo, ma dopo tutto temporaneo.
p. 76
E continuavano a circolare per le strade e a mettersi ai tavolini sulla terrazza dei caffè. Nel complesso, non erano vili, si scambiavano più storielle che lagnanze, e mostravano di accettare con buonumore degli inconvenienti evidentemente passeggeri. Le apparenze erano salvate.
pp. 76-77
Sono cose che accadono a tutti: ci si sposa, ci si ama ancora un po’, so lavora. Si lavora tanto che si dimentica l’amore.
p. 80
Dopo quelle settimane spossanti, dopo tutti quei crepuscoli in cui la città si riversava nelle strade per girarvi intorno, Rieux capiva che non aveva più da difendersi contro la pietà. Ci si stanca della pietà, quando la pietà è inutile. E nella sensazione del suo cuore chiuso lentamente su sé stesso, il dottore trovava l’unico sollievo alle massacranti giornate.
p. 88
“M’intenda bene, dottore. A rigore, è assai facile scegliere tra ma ed e; la difficoltà aumenta con poi e quindi; ma certamente la cosa più difficile è sapere se bisogna mettere una e o se non bisogna.”
pp. 99-100
Al principio dei flagelli e quando sono terminati,
p. 112
si fa sempre un po’ di retorica.
Nel primo caso l’abitudine non è ancora perduta,
e nel secondo è ormai tornata.
Soltanto nel momento della sventura
ci si abitua alla verità, ossia il silenzio.
Aspettiamo.
“Lei pensa tuttavia, come Paneloux, che la peste porta un suo beneficio, che apre gli occhi, che costringe a pensare!” (…) “Come tutte le malattie di questo mondo. Ma quello che è vero dei mali di questo mondo è vero anche della peste. Può servire a maturar qualcuno. Ciononostante, quando si vedono la miseria e il dolore che porta, bisogna essere pazzi, ciechi o vili per rassegnarsi alla peste.”
p. 121
Il male che è nel mondo viene quasi sempre dall’ignoranza, e la buona volontà può fare guai quanto la malvagità, se non è illuminata.
p. 126
… i mezzi per lottare contro la peste non erano numerosi abbastanza. “Manchiamo di materiale,” disse. “In tutti gli eserciti del mondo, in genere, si supplisce alla mancanza di materiale con gli uomini. Ma noi manchiamo anche d’uomini.”
p. 143
“Ecco: lei è capace di morire per un’idea, è visibile a occhio nudo. Ebbene, io ne ho abbastanza delle persone che muoiono per un’idea. Non credo all’eroismo, so che è facile e ho imparato ch’era omicida. Quello che mi interessa è che si viva e che si muoia di quello che si ama.“
p. 156
“… qui, non si tratta d’eroismo, si tratta d’onestà. E’ un’idea che può far ridere, ma la sola maniera di lottare contro la peste è l’onestà.“
p. 157
PARTE TERZA
Nel centro stesso della città si ebbe l’idea di isolare certi quartieri particolarmente colpiti, e di non autorizzare a uscirne che gli uomini i cui servizi fossero indispensabili. Coloro che sino allora vi erano vissuti non poterono fare a meno di considerare questa misura come una vessazione particolarmente diretta contro di loro, e in ogni caso pensavano, per contrasto, agli abitanti degli altri quartieri come a uomini liberi. Questi ultimi, in cambio, nei momenti difficili trovavano una consolazione nell’immaginare che altri erano ancora meno fortunati di loro. “C’è sempre uno più prigioniero di me”, era la frase che riassumeva allora la sola speranza possibile.
p. 161
Ebbene, quello che caratterizzava, in principio, le nostre cerimonie era la rapidità; tutte le formalità erano state semplificate e, in maniera generale, la pompa funeraria era stata soppressa. I malati morivano lontani dalle loro famiglie, le veglie rituali erano state proibite, di modo che chi era morto in serata passava la notte da solo, e chi moriva in giornata era sepolto senza indugio. Si avvertiva la famiglia, beninteso, ma, nella maggior parte dei casi, questa non poteva spostarsi, essendo in quarantena s’era vissuta accanto al malato. Nel caso in cui la famiglia non abitasse col defunto, si presentava all’ora indicata, ossia a quella della partenza per il cimitero, il corpo essendo stato ormai lavato e messo nella bara.
p. 165
… l’abitudine alla disperazione
p. 174
è peggiore della disperazione stessa.
PARTE QUARTA
Questo era il vero pericolo: era la stessa lotta contro la peste a renderli allora i più vulnerabili alla peste. Insomma, scommettevano sul caso e il caso non è di nessuno.
p. 184
Gli spettacoli di morte non gli erano mancati; e sebbene, di regola, fosse protetto dal siero, il pensiero della propria morte non gli era rimasto estraneo.
p. 209
… i cimiteri erano disertati. (…) quell’anno, nessuno voleva pensare ai morti; ormai vi si pensava, forse, anche troppo; e non si trattava più di tornare a loro con un pò di rimpainto e con molta malinconia. Essi non erano più i trascurati, presso i quali si viene a giustificarsi un giorno all’anno; erano gli intrusi che si vogliono dimenticare. Per questo il Giorno dei MOrti, quell’anno, fu, in qualche maniera, sabotato. (…) ogni giorno era il Giorno dei Morti.
p. 224
E mentre la peste, con l’efficace imparzialità che arrecava nel suo ministero, avrebbe dovuto rafforzare l’eguaglianza presso i nostri concittadini, col gioco normale degli egoismi, invece rendeva più acuto nel cuore degli uomini il sentimento dell’ingiustizia. Restava, beninteso, l’eguaglianza incensurabile della morte, ma, di questa, nessuno ne voleva sapere.
p. 226
Non c’era più posto nel cuore di tutti che per una vecchissima e tristissima speranza, la stessa che impedisce agli uomini di lasciarsi andare alla morte, e che non è se non una semplice ostinazione a vivere.
p. 248
“Ci siamo,” diceva, “escono ancora.”
p. 253 (regresso del contagio)
“Chi?”
“Ebbene, i sorci!”.
Dopo il mese d’aprile, nessun sorcio morto era stato trovato.
“Che si stia per ricominciare?” disse Tarrou a Rieux.
Il vecchio si fregava le mani.
“Bisogna vederli correre, è un piacere!”
PARTE QUINTA
Quantunque l’improvviso regresso della malattia fosse insperato, i nostri concittadini non si affrettarono a rallegrarsi. I mesi passati, accrescendo il loro desiderio di liberazione, insieme gli avevano insegnato la prudenza e li avevano abituati a contare sempre meno in una fine prossima del contagio. Ciononostante, il fatto nuovo era su tutte le bocche, e in fondo ai cuori si agitava una grande speranza inconfessata. Tutto il resto passava in seconda linea. Le nuove vittime della peste pesavano ben poco in paragone del fatto esorbitante: le statistiche indicavano una diminuzione.
p. 255
Ma di tanto in tanto la malattia s’irrigidiva, e in una sorta di cieco soprassalto si portava via tre o quattro malati di cui si sperava la guarigione: erano i malavventurati della peste, gli uccisi in piena speranza.
p. 257
… il contagio poteva considerarsi arginato. (…) anche per molti che erano in lutto, il sollievo fu profondo, sia che la paura di vedersi rapiti altri congiunti fosse calmata, sia che il sentimento della loro personale conservazione non fosse più in allarme.
pp. 259-260
Ma le famiglie che dovevano restare più estranee alla gioia generale furono quelle, senza dubbio, che in quello stesso momento avevano un malato alle prese con la peste in un ospedale e che, in una sede di quarantena o nelle proprie case, aspettavano che il flagello la finisse veramente con loro, come l’aveva finita con gli altri. (…) Ma tali eccezioni nulla toglievano alla contentezza degli altri.
p. 260
Quanto l’uomo poteva guadagnare,
p. 278
al gioco della peste e della vita,
era la conoscenza e la memoria.
Ma se questo era guadagnar la partita, come doveva esser duro vivere soltanto con quello che si sa e che si ricorda, e privi di quello che si spera.
p. 278
(battute di chiusura)
Ascoltando, infatti, i gridi di allegria che salivano dalla città, Rieux ricordava che quell’allegria era sempre minacciata: lui sapeva quello che ignorava la folla, e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che si può restare per decine d’anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valige, nei fazzoletti e nelle cartacce e che forse verrebbe giorno in cui, sventura e insegnamento agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi sorci per mandarli a morire in una città felice.
pp. 294-295
Camus, A. (1961). La Peste. Milano: Bompiani